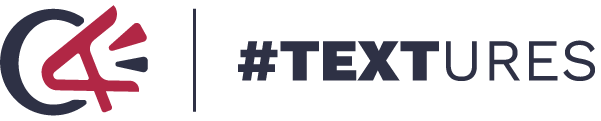09 Lug L’evoluzione del Brand Activism Da ‘Dream Crazy’ al caso Zara
A cura di Elena Urbinati
Una campagna che ha fatto la storia
2018. Nike lancia la campagna promozionale ‘Dream Crazy’, che vede la partecipazione dell’ex quarterback afroamericano Colin Kaepernick. Il testimonial, figura di spicco della National Football League, a partire dal 2017 era stato escluso dal campionato per le sue azioni di protesta contro le ingiustizie razziali negli Stati Uniti.

Fonte: The Guardian
Allora, la presa di posizione di Nike non provocò effetti particolarmente indesiderati, perché contribuì a dare visibilità online sia al brand che a Kaepernick stesso e alla vicenda che lo vedeva coinvolto (Balzano et al., 2018). Ma a distanza di sei anni, cosa è cambiato nel panorama del brand activism?
Uno scenario mutato
Per poter rispondere a questa domanda è opportuno esaminare il percorso che ha portato il mondo corporate a scegliere la via dell’attivismo. Storicamente, questa pratica si ispira ai principi di CSR e ai criteri ESG. Tuttavia, si differenzia da entrambi poiché non si limita a sostenere questioni già ampiamente riconosciute come rilevanti – come garantire l’accesso ai servizi sanitari – ma si impegna a prendere posizione su cause sociali potenzialmente divisive, come i diritti riproduttivi (Herzberg e Rudeloff, 2022).

Fonte: The Marketing Journal
In questo modo, le aziende costruiscono attorno a sé una nutrita comunità di consumatori che si identificano nel brand e nella visione del mondo di cui si fa portavoce. Negli ultimi tempi però questa pratica sta conoscendo una fase di decrescita, nonostante i temi controversi continuino ad affollare le arene mediali.
Come afferma Serazio (2024), la ragione potrebbe derivare dal fatto che “il marketing cavalca i trend, non li guida; ha bisogno di mercati, non di essere etico”. Di conseguenza, si pone per le aziende la necessità di bilanciare l’impegno sociale in funzione dei propri pubblici, nella consapevolezza che schierarsi significa alienarsi una parte del proprio mercato.
Inoltre, l’entrata in un periodo inflazionistico ha portato all’emergere di nuove priorità, legate soprattutto al costo della vita e meno ad un marketing di tipo valoriale. Ciò si traduce in una comunicazione più pragmatica che simbolica, che prende le distanze da questioni di attualità giudicate troppo sensibili per poter diventare oggetto di una campagna (come la guerra a Gaza), al punto che anche associazioni non intenzionali con questi temi possono portare a boicottaggi e proteste (come nel caso della recente campagna ‘The Jacket’ promossa da Zara).

Fonte: The New York Times
Infine, in questo campo aleggia costantemente lo spettro dello slacktivism, un fenomeno che si verifica quando le aziende prendono posizione senza al contempo assumersi impegni precisi nei confronti della collettività. I consumatori, sempre più consapevoli e informati, sono diventati abili nel riconoscere quando un’azienda sta semplicemente cavalcando l’onda del momento per ottenere visibilità.
In definitiva, l’evoluzione che ha conosciuto il brand activism in questi anni evidenzia come l’impegno sociale delle aziende sia di volta in volta frutto di una precisa scelta di posizionamento strategico, in linea con obiettivi e valori ben definiti. In questo senso, l’immagine che i brand proiettano all’esterno rispecchia prima di tutto gli interessi aziendali e non quelli collettivi, la cui tutela spetta a soggetti indipendenti slegati da considerazioni di mercato.
Riferimenti bibliografici e sitografici
- Balzano, G. (2018). “Il brand activism. L’attivismo sociale del brand”. Comm To Action. Link
- Fadulu, L. (2023, 12 dicembre). “Zara Removes Campaign After Critics Call It Insensitive to Israel-Hamas War”. The New York Times. Link
- Herzberg, M., e Rudeloff, C. (2022). “Should your brand take a stand? Comparing the impact of brand activism and CSR on brand equity”. Journal of Brand Strategy, 11(3), 248-262. Link
- Serazio, M. (2024, 29 maggio). “Your favorite brand no longer cares about being woke”. Vox. Link