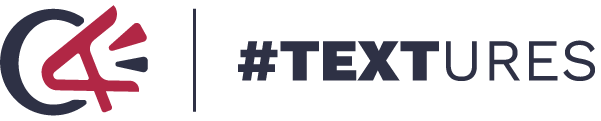17 Mar COGNITIVE WARFARE: IL DESTINO DELLA GUERRA

Fonte immagine: https://www.pexels.com/it-it/
a cura di Edoardo Natali
Negli ultimi anni sono quasi improvvisamente sorti nuovi esempi di violenza sistematica, come la guerra russo-ucraina o quella israelo-palestinese. Nonostante questa nuova esposizione agli eventi bellici, soprattutto in Europa persiste una mancanza di consapevolezza dei livelli più profondi e avanguardistici che ha raggiunto la pratica della guerra. Infatti oggi giorno, oltre al conflitto convenzionale, viene applicata la “guerra cognitiva” (“Cognitive Warfare“), anche definita “guerra ibrida”. Nonostante la sua storia sia particolarmente recente e il termine sia stato usato per la prima volta nel 2017 dal generale dell’aeronautica degli Stati Uniti David Goldfein, i suoi primi sviluppi sono osservabili già nella Seconda Guerra Mondiale e nella Guerra Fredda. È stato in questo periodo che Stati Uniti e Unione Sovietica fecero le prime ricerche sul controllo mentale, sulla fabbricazione di consenso e sulla manipolazione delle masse. Questo nuovo orizzonte di guerra, attraverso l’uso di pratiche psicologiche e cibernetiche, cerca di esercitare un’influenza su una determinata popolazione o nazione targettizzate nel tentativo di modificare, indebolire e frammentare le loro idee e atteggiamenti. L’obiettivo è quello di costruire una realtà parallela grazie alla quale le persone finiscono per condividere i punti di chi ha creato la campagna di comunicazione. Così facendo, succede che si provochino radicalizzazioni e polarizzazioni negli individui e nelle comunità prese di mira. In più, stati come Stati Uniti, Russia, Cina e Giappone, hanno portato la guerra ad una dimensione che coinvolge non solo progetti di natura puramente bellica, ma anche di natura neuroscientifica applicata al militare chiamati “brain”.
Indubbiamente lo strumento più forte e influente di questo nuovo scenario di guerra, oltre alla propaganda e alla gestione delle informazioni, è la disinformazione. All’interno del suo campo d’azione ci sono altre due pratiche: la “misinformation”, che è la condivisione e il riecheggiamento di informazioni non verificate, e la “mala-informazione”, che utilizza le fughe di notizie o la diffusione di informazioni segrete o codificate. È molto diffusa anche l’“infodemia”, cioè la circolazione caotica di grandi blocchi di informazioni né controllate né razionalmente articolate che impediscono alle persone di formarsi un’idea logica e fondata su determinati argomenti.

Fonte immagine: https://www.pexels.com/it-it/
Naturalmente, in maniera sempre più massiccia a partire dallo scoppio della guerra in Ucraina, il Web è diventato il teatro principale di questo genere di operazioni, tanto vero che esse hanno coinvolto sempre di più l’uso di influencer, challenge e, soprattutto, meme. Questi ultimi, infatti, molto diffusi tra le giovani generazioni Y e Z, possono essere estremamente potenti nel diffondere in modo sottile narrazioni efficacemente non solo perché sono difficili da moderare, ma anche perché traducono idee complesse in messaggi semplici ed emotivamente coinvolgenti che attingono da schemi mentali preesistenti.
Generalmente, la conseguenza principale della disinformazione è di intrappolare gli individui in contraddizioni da cui è difficile liberarsi. Oltre ai classici paradossi riguardanti il problema del sovraccarico informativo, della trasparenza sui social e della sovrastimata ricerca della viralità, fondamentali da considerare sono l’effetto boomerang e il paradosso della verità-informazione. Il primo porta una falsità ad essere rafforzata man mano che la si cerca di correggere, mentre il secondo sfrutta le situazioni polarizzate per trasformare i fatti in posizioni politiche.
Alla luce di tale contesto, il crescente ruolo dell’informazione nell’arte della guerra costituisce un segnale che suggerisce l’importanza dell’aggiornamento costante su come venga gestita internazionalmente l’informazione, in modo tale da rafforzare la futura difesa nazionale.
Ma come fare quando la comunicazione viene manipolata in momenti di particolare attenzione e sensibilità come le elezioni di cariche governative? Ne parleremo molto presto in un prossimo articolo.
Fonti:
https://qi.hogrefe.it/rivista/cognitive-warfare-aspetti-psicologici-e-uso-dei-social-media/
Emanuel Pietrobon, Guerra cognitiva. La nuova minaccia ibrida, Machiavelli Dossier, n. 42 – 22 luglio 2023.
Stato Maggiore della Difesa, Cognitive Warfare. La competizione nella dimensione cognitiva, Ministero della Difesa, Edizione 2023.